Il nuovo editoriale di Storyword*, una sintesi ragionata delle notizie più significative apparse sui media, nazionali ed internazionali, sull’informazione e la comunicazione nell’epoca digitale. Con attenzione ai fatti più rilevanti della comunicazione politica, fake news, censura.
Google, tra notizie…
Google dovrebbe versare nelle casse degli editori statunitensi più di 10 miliardi di dollari all’anno. È quanto emerso da uno studio pubblicato dall’Institute for Policy Dialogue della Columbia University, che sostiene che il colosso di Mountain View dovrebbe distribuire annualmente alle società di news il 17,5% dei ricavi derivanti dalla ricerca. Mentre Meta, secondo gli stessi calcoli, il 6,6% delle entrate pubblicitarie, poco meno di 2 miliardi di dollari all’anno. I risultati della ricerca sono frutto di un lavoro molto complesso in virtù della mancanza di dati disponibili sul comportamento del pubblico. Motivo per cui Google, racconta Semafor, rifiuta sia la metodologia dello studio sia i suoi risultati. La portavoce della compagnia ha affermato che “meno del 2% di tutte le ricerche sono legate alle notizie” e che Google apporta “un enorme valore ai siti di notizie generando più di 24 miliardi di visualizzazioni ogni mese sui loro portali – senza alcun costo per quest’ultimi – che possono monetizzare”. La battaglia tra società di news e big tech va avanti ormai da diversi anni. Gli scontri più noti si sono verificati nel 2021 in Australia con l’Australian News Media Bargaining Code, che ha garantito milioni di dollari al business dell’informazione, e recentemente in Canada con l’Online News Act che impone alle piattaforme di pagare le testate giornalistiche per i loro contenuti. In risposta a questi provvedimenti legislativi, Google ha iniziato a firmare accordi di pagamento direttamente con gli editori di tutto il mondo. Accordi i cui importi e metodologia con cui vengono calcolati non sono pubblici, generando una criticità per le testate minori a cui di conseguenza mancano le basi per trattare con le big tech. E ciò deriva anche dal fatto che, a differenza degli attori di Hollywood, non esiste un grande sindacato dei giornalisti.
…e libertà di espressione
Da quando è scoppiato il conflitto tra Hamas e Israele(vedi Editoriale 149 ed Editoriale 150), Google, nota per essere una realtà inclusiva e aperta, è diventata intollerante nei confronti dei sostenitori dei palestinesi. Come riporta il New York Times (che ha discusso la questione con sette dipendenti di Google), molti lavoratori lamentano un clima ostile, in netta contrapposizione ai valori aziendali: il dibattito sul conflitto in Medio Oriente è sfociato nell’intolleranza. Qualsiasi tipo di critica allo Stato israeliano può essere facilmente interpretata come antisemitismo. Un gruppo di lavoratori ha quindi deciso di pubblicare una lettera aperta indirizzata alla dirigenza di Google, accusando l’azienda di avere un doppio standard che consente “la libertà di espressione per i Googler israeliani rispetto ai Googler arabi, musulmani e palestinesi”. I dipendenti filo-palestinesi affermano che l’azienda ha permesso ai sostenitori di Israele di esprimere liberamente le loro opinioni, mentre ha attaccato i dipendenti musulmani che hanno criticato la rappresaglia di Israele a Gaza. Anche altre realtà della Silicon Valley stanno riscontrando problemi simili, ma ciò stride ancora di più se si pensa che Google è diventata negli ultimi anni un centro di attivismo per i dipendenti, un’eredità della cultura aperta e informale della società. La lettera fa emergere anche un altro punto dolente: il ruolo di Google in un contratto da 1,2 miliardi di dollari (Nimbus) per fornire a Israele e alle sue forze armate strumenti di intelligenza artificiale. Tecnologia che, secondo critici e attivisti, potrebbe essere usata per sorvegliare i palestinesi. L’azienda nega che Nimbus nasconda scopi di questo genere. Il risultato è che i dipendenti palestinesi, arabi e musulmani sentono minacciata la loro libertà di opinione e sono “profondamente colpiti da un preoccupante aumento dell’islamofobia mentre osservano con terrore la condizione dei civili palestinesi a Gaza”. In un dibattito così delicato e divisivo l’unico approccio possibile e tollerato sembra essere “condannare Hamas e passare oltre”.
Threads, un primo bilancio
Fin dal suo lancio, gli esperti si sono chiesti se Threads (un’applicazione che fin da subito si è posta come l’anti Twitter) sarebbe stata in grado di competere con il social di Musk. A soli quattro mesi dalla sua nascita, l’app di Zuckerberg è diventata un vero concorrente di X, e lo ha fatto molto più velocemente di quanto molti si aspettavano: la piattaforma, infatti, ha raggiunto trenta milioni di iscritti entro ventiquattro ore dal suo lancio (vedi Editoriale 139). In una recente conferenza, Mark Zuckerberg ha affermato che l’app ha raggiunto quasi un centinaio di milioni di utenti mensili, dato che fa di Threads una delle app di più rapida crescita nella storia. In questo scenario, come riporta Columbia Journalism Review, i giornalisti sembrano reputare Threads sempre più utile. Il mese scorso Casey Newton ha scritto nella sua newsletter Platformer che il conflitto tra Israele e Hamas ha aiutato Threads a emergere quale social per confrontarsi, recuperare testimonianze e opinioni, soprattutto tra cronisti. In altre parole, quello che fino a ieri ha sempre fatto X. La piattaforma di Elon Musk, a seguito delle novità introdotte, non facilita più le persone a distinguere le notizie attendibili dalle altre. Questo, invece, Threads permette ancora di farlo, e sempre più giornalisti sembra lo stiano scoprendo.
Il virus di BoJo
Byline Times dedica un articolo alla gestione del governo britannico durante la crisi generata dal Covid-19, evidenziando il ruolo dei media, in particolare del Telegraph e del Mail, nel plasmare la strategia di Boris Johnson. L’articolo sostiene che la strategia iniziale del governo fosse quella di lasciare il virus diffondersi per raggiungere l’immunità di gregge entro settembre 2020. Viene citata la dichiarazione di Boris Johnson a Greenwich, sottolineando la priorità data all’economia rispetto alla salute pubblica, oltre che la minimizzazione del pericolo del virus da parte dei media, con particolare attenzione alla promozione dell’immunità di gregge come soluzione all’epidemia dilagante. L’articolo si pone come critica al ruolo al sistema mediatico, accusato di incoraggiare il governo a ignorare la scienza e adottare decisioni dannose. Oggi i media sembrano però avere anche imparato dalla lezione Covid, cercando di evitare le fake news, dire onestamente ciò che si sa e ciò che non si sa, e mettere in disparte i complottisti piuttosto che metterli al centro della conversazione (vedi Editoriale 143). Anche se nell’aria aleggia ancora lo spettro della censura tanto usata in paesi come la Cina che ha preso di mira riviste internazionali e database scientifici, scuotendo le fondamenta della conoscenza scientifica condivisa rispetto alla pandemia (vedi Editoriale 128).
Paura della ricerca scientifica
Una parte della politica appare più minacciata dall’attività di ricerca sulla disinformazione che dai rischi per la democrazia derivanti dalla disinformazione stessa. È quanto scrive Joshua Benton su Nieman Lab, citando un nuovo paper intitolato “Misinformation and the Epistemic Integrity of Democracy”, realizzato da ricercatori di diverse università, tra cui Harvard e Cambridge. Gli autori della ricerca sostengono che la democrazia si basa su un insieme di conoscenze condivise tra i cittadini e analizzano le campagne di disinformazione che stanno minando queste conoscenze. Campagne che producono attacchi agli scienziati che vengono costantemente screditati inducendo l’opinione pubblica – ma anche gli intellettuali – a mettere in dubbio i fatti, minando la stabilità del sistema democratico.
Eccentrica generosità
“Sei seduto?”. Con questa domanda è cominciata, vent’anni fa, una telefonata tra Kevin Close, presidente della National Public Radio (NPR) e Dick Starmann, consigliere della vedova di Ray Kroc, colui che ha trasformato McDonald’s in un fenomeno globale. A ricordare questa storia è il Washington Post, che di questa conversazione mette subito in luce anche l’esito, cioè una generosa donazione da parte della signora Kroc, determinante per accelerare la crescita dell’emittente radiofonica. Per quest’ultima non è sempre stato tutto rose e fiori, nonostante le disponibilità finanziarie dovute a quella generosa donazione, una delle tante di Mrs Kroc. La signora, infatti, è stata, in vita, quello che il Washington Post ha definito “una filantropa prodigiosa, ma idiosincratica”. Una descrizione calzante, se si considerano i destinatari della sua generosità: programmi per combattere l’alcolismo, il movimento per il disarmo nucleare, la ricerca contro l’AIDS, corsi di “Peace Studies”. E allora, perché la NPR? Non tutte le fonti sono concordi nel dire che fosse un’avida ascoltatrice, mentre c’è più consenso intorno all’ipotesi dell’ammirazione nei confronti di Klose, verso il quale mostrerà generosità fino alla fine, tra ulteriori donazioni da milioni di dollari, party e promesse di grandi cose da fare insieme… e assegni festeggiati mangiando Big Mac.
Non perdere di vista lo scopo
Quando i leader stabiliscono una linea chiara che collega il lavoro individuale di ogni dipendente al purpose aziendale, allora tutti possono vedere la loro parte nell’insieme più grande. Dopo aver dimostrato come il purpose sia fondamentale anche per generare profitto (vedi Editoriale 149), a valle di uno studio che ha coinvolto 150 aziende, gli autori di Harvard Business Review sottolineano l’importanza di mantenere vivo lo scopo aziendale nelle attività quotidiane, evidenziando come molte organizzazioni faticano a farlo a causa di una disconnessione emotiva tra lo scopo dichiarato e i ruoli individuali dei dipendenti. A tal proposito HBR ha individuato tre strategie per aiutare i dipendenti a mantenere questa connessione. Prima di tutto, far riflettere i dipendenti sull’effetto a catena del loro lavoro, aiutandoli a capire come le loro attività influenzano gli altri e contribuiscono allo scopo più ampio, riflettendo su domande come: “qual è il risultato del mio lavoro?”. In secondo luogo, riformulare le misure del successo, collegando le metriche quantitative a impatti umani più significativi. Infine, sottolineare l’importanza di celebrare non solo i successi interni, ma anche l’impatto esterno del lavoro dell’organizzazione.
*Storyword è un progetto editoriale a cura di un gruppo di giovani professionisti della comunicazione che con diverse competenze e punti di vista vogliono raccontare il mondo della comunicazione globalizzato e in costante evoluzione per la convergenza con il digitale. Storyword non è una semplice rassegna stampa: ogni settimana fornisce una sintesi ragionata dei contenuti più significativi apparsi sui media nazionali ed internazionali relativi alle tecniche e ai target di comunicazione, sottolineando obiettivi e retroscena. Per maggiori informazioni: http://www.storywordproject.com

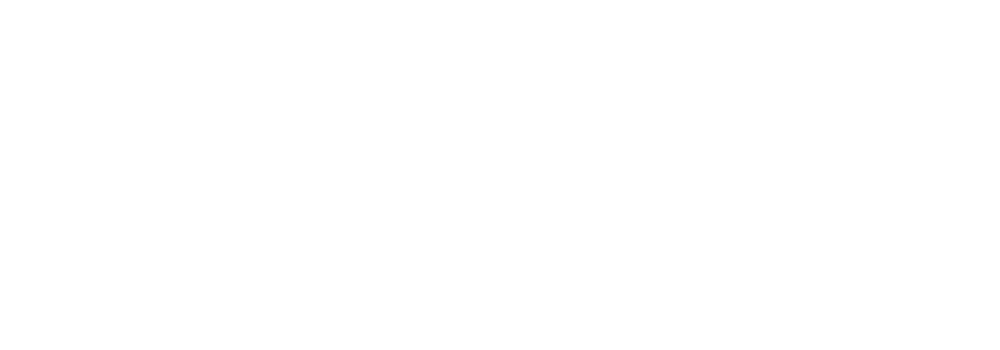


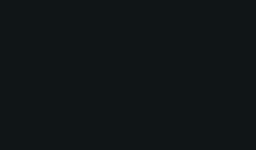

Leave a comment